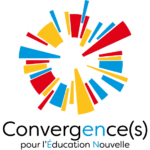EDUCAZIONE INVISIBILE
Articolo redatto per il Convegno: Visioni di futuro, visioni di teatro
28 febbraio 2015 – Bologna – Teatro Testoni Ragazzi
Il titolo di questo intervento (era previsto Vedere e non vedere ed è diventato Educazione invisibile) è variato nel corso di un incontro con un bambino. Lui stava facendo qualcosa ed io lo stavo guardando. Ad un certo punto mi ha detto: “Guardami. Dimmi cosa vedi”. Io pensavo di dirgli che vedevo lui, i suoi pennarelli, il suo disegno… Ma lui alludeva a qualcosa di altro. Forse a qualcosa che aveva nascosto alla mia vista. A qualcosa di non visibile.
Ho pensato a quante volte si vedono i bambini attraverso quello che fanno o nel loro comportamento esteriore. Molto più difficile è riconoscere quello che non si può vedere, un invisibile che può essere celato volutamente, ma che più spesso è frutto della nostra incapacità ad andare al li là dell’immediato. Come in quell’immagine ambigua dove appare in primo piano un volto di una persona anziana, e poco a poco si riesce ad intravedere un secondo, un terzo un quarto personaggio (fino a nove). Tutti questi volti c’erano anche nei primi momenti che abbiamo visto l’immagine, ma nel primo momento noi non li mettevamo a fuoco e rimanevano perciò, per noi, invisibi
Visioni? Il termine visione ci avvicina al termine utopia; la parola utopia ci porta a pensare ad un modello ideale; un modello ideale, tende pericolosamente verso un’ideologia; l’ideologia si muta facilmente in potere estremo … Dobbiamo allora guardarsi dalle visioni? No, perché avere una visione è importante, come pure è necessario immaginare un’utopia. Ma per salvarsi dalla deriva che ci può trascinare verso un potere malsano, occorre pensare ad utopie concrete, occorre avere visioni possibili, occorre saper vedere l’invisibile (vicino e lontano).
Le relazioni si costruiscono nelle situazioni concrete. Adulto e bambino sono termini che rappresentano un’astrazione, ci danno una visione stereotipata, generica, buona per tutte le occasioni. Le situazioni concrete mutano i rapporti e modificano le visioni. Relazionarsi con un bambino o con tanti non è la stessa cosa e non produce le stesse relazioni. Anche un singolo bambino non è un “bambino”, ma Alessio, Caterina, Francesco …
La forma e talvolta la sostanza dei rapporti, cambiano con il cambiare del contesto. Il cum-textusè un intreccio che determina i comportamenti, è un tessuto, fatto di fili. Quando qualcuno tira troppo il filo da tessere, le spezza o produce dei nodi anziché della stoffa. La relazione (interazione) soggetto/soggetto impone che si guardi il rapporto bambino/adulto, all’interno del textus nel quale queste persone sono inserite.
Occorre imparare a vedere ed a gestire i fili del contesto, perché non si annodino. Uno dei nodi che facilmente vengono a formarsi è il nodo del Potere. Il potere non è un termine negativo. La sua presenza è parte della vita dei bambini e degli adulti. Si cresce esercitando o reagendo ai poteri (nostri o di altri) che si incontrano nella vita (nel rapporto con la famiglia, con gli adulti, con le regole, con se stessi…). “Volere è potere, tutto il resto sono scuse”, dice un vecchio detto. Il potere occorre riconoscerlo, guardarlo in faccia, non subirlo, imparare a gestirlo. La questione del potere, si risolve quando siamo in grado di vederla e di occuparcene.
Il potere si struttura in modi diversi, a seconda contesto (cum-textus). Imparare a gestire i fili del contesto significa anche riconoscere gli intrecci ed i nodi della trama. Non sempre questi nodi sono visibili.
Le visioni, per diventare utopie concrete, devono saper vedere anche l’invisibile. L’esercizio del potere è un invisibile che può anche diventare visibile, se si affrontano le domande che lo competono.
Chi prevale nelle diverse situazioni relazionali? Quali interazioni prevalgono di fronte ad una o a molte persone? Valgono sempre le regole pedagogiche (e umane) della dignità, del rispetto, della nonviolenza, dell’agio, o prevale il potere (che è anche il volere, il desiderio…) del più forte? E quali sono i poteri forti che agiscono in una situazione educativa di tipo teatrale?
Nel lavoro teatrale i poteri sono molti:
– C’è il potere del bambino che vuol ottenere quel qualcosa che si è prefissato (più o meno consapevolmente: sfuggire ad un clima familiare noioso o autoritario; o provare a seguire i compagni che già fanno quella cosa; o imitare personaggi ritenuti famosi dai mass media; o anche tentare di mostrare di essere proprio lui (anche quando si trova a diventare un personaggio teatrale). I bambini non sono spontanei e creativi. Anselmo Bucci (1887-1955), detto il pittore volante, scriveva: “Ridi della così detta spontaneità. Non c’è erba più spontanea dell’ortica. Spontaneamente saremmo tutti cannibali.” Forse la frase è un po’ forte, ma sta ad indicare che la spontaneità e la creatività vanno costruite, coltivate, sviluppate, sostenute. Senza questo sforzo (che tocca agli adulti)
– C’è il potere del testo che può essere costruito, adattato, rimodellato, cambiato … Vale per gli adulti e vale nel lavoro con i piccoli. Il testo, anche se prodotto dai bambini, impone sempre (per fortuna) di rallentare il tempo, di ripensare, di procedere con calma, di gustare il senso della durata. E richiede il rispetto delle sue tre regole fondamentali: offrire qualcosa di “nuovo”, di inedito, di diverso, di creativo; mostrare una coerenza interna, una organizzazione comprensibile ed essenziale (Bruno Munari, scriveva che la creatività “ è tutto ciò che prima non c’era ma realizzabile in modo essenziale e globale.). E deve essere adatto all’esterno, perché il pubblico deve poter condividere il senso di quel messaggio teatrale che a lui viene offerto. In francese fare delle prove per dare forma ad un’idea teatrale si dice répétition, ri-petizione che nel senso letterale del termine (ri-petere) significa “domandare e continuare a domandare più volte”. Franco Lorenzoni riportando la sua esperienza con i bambini nelle classi della scuola primaria, scrive: “mi rendo conto di quanto il teatro ci aiuti a fermarci e sostare a lungo sulle cose. Come ci aiuti a sperimentare il senso della durata, così avvilito oggi dalla girandola di stimoli che circondano i bambini, in un
tempo che li vuole solo consumatori compulsivi” (I bambini pensano grande, Sellerio)
– C’è il potere del regista che (con una funzione di animatore o di insegnante), esercita il proprio ruolo). Un adulto che spesso si sente oppresso (e fa sentire) il potere del tempo, la sua “scarsità” (dobbiamo terminare entro…), che spinge ad accelerare e a produrre adrenalina. C’è un cartello all’ingresso del campo sportivo della Città di Opera, dove si “allenano” i bambini al gioco del calcio. Dice: “Chi pensa di avere un figlio ‘campione’ è pregato di portarlo in altre società”. Un cartello simile dovrebbe stare attaccato in ogni scuola di teatro per i bambini. Certo, l’adulto ha il potere, ma anche il dovere: quello di accettare, proporre, lasciare esistere, perché “i processi decisionali dei bambini e dei ragazzi potranno progredire, e così il loro senso critico, se gli adulti si dimostreranno capaci di infondere in loro il coraggio e la responsabilità di una scelta autonoma” (P. Sollier, Calci, sputi e colpi di testa , Kaos Edizioni).
– C’è il potere del gruppo (che può affermarsi al di là del previsto). C’è stato un periodo nel quale fare teatro con i bambini voleva dire che la relazione all’interno dei partecipanti era prioritaria rispetto a tutto il resto. Era l’epoca dei laboratori teatrali adulti di narrazione autobiografica, dove il lavoro teatrale “si consuma totalmente all’interno del gruppo che lo produce; è qualcosa di gratuito che vale nel tempo, più o meno breve, richiesto dalla preparazione e dalla realizzazione”, perché la drammatizzazione ha come scopo “capire come un problema umano e culturale viene percepito dal gruppo e come possa diventare conquista e controllo critico della propria sensibilità al problema”. Fare teatro era costruire un percorso per avere coscienza “di essere un gruppo e concordemente esprimersi di fronte ad un problema o a un argomento di comune interesse” (G. Blasich, La drammatizzazione nella scuola, Elledici)). Il potere del gruppo va saputo gestire, scegliendo didattiche dolci, come quella “antica” del gioco drammatico. Léon Chanterel nel 1939 (Les jeux dramatiques, Les Editions du Cerf), sull’onda dei laboratori teatrali adulti che si erano sviluppati nella prima metà del secolo, aveva proposto il termine jeux dramatique, con un’aggiunta: doveva essere un teatro nel quale si doveva sviluppare l’orchestique, la capacità di sviluppare tutti gli elementi dell’arte drammatica (così come viene ricordata dalla letteratura greca). I CEMEA propongono da anni corsi residenziali di formazione dedicati al gioco drammatico. Un teatro-gioco nel quale c’è il mettersi alla prova, c’è una esposizione di sé, ma c’è anche la consapevolezza di dovere controllare le proprie pulsioni e le specifiche esigenza in funzione di uno scopo che comprende e non esclude le esigenze dei singoli. Se fare teatro è osare, allora occorre serenità, ascolto. Si può osare se siamo sicuri di essere accolti, così come siamo.
– C’è il potere dell’immaginario (che si nasconde nelle menti dei bambini e degli adulti); la cultura del nostro tempo crea un’infinità di immaginari. Altera il rapporto fra reale e fantasioso, a discapito della percezione del reale (come il bambino-Batman che si lancia dall’armadio); o con una trasformazione del quotidiano in consuetudinario (“è così che si fa”, al posto di “è così che mi trovo a dover fare”); e con una insistenza esasperante sulla velocizzazione.“Fatto. Ho chiuso la faccenda, posso recuperarla nella mente quando ne avrò bisogno, non devo più pensarci. Così impediamo alla mente di memorizzare a attivare le procedure relative” M. Spitzer, Demenza digitale, Corbacao). Una vita “troppo piena” di immagini, di stimoli, di eventi non consente di ripensare, di esprimere ciò che si prova, ciò che si immagina. La velocità del pensiero non corrisponde alla velocità dei sensi che incamerano gli stimoli. Le sensazioni vanno elaborate, perché diventino percezioni e poi riflessioni. Altrimenti si rimane in superficie e, insoddisfatti, si reitera l’azione.
Come regolare questi diversi poteri che agitano adulti e bambini? Come destreggiarsi in un lavoro teatrale che rappresenta non soltanto ciò che viene rappresentato, ma anche l’invisibile che ci rappresenta? Perché, come dice un bambino della classe di Lorenzoni, a proposito dell’arte: “è come se quello che facciamo siamo noi”. Noi agiamo sulle cose, ma non siamo separati dalle cose. Come dire: i mezzi (il processo) non possono che essere legati al fine (il prodotto). In educazione non si può ottenere un prodotto finale se non viene valorizzato (con il rispetto, la calma, l’attenzione, la cura) tutto il processo che lo precede, che – come si è detto – è tirato da fili di potere a volte invisibili.
Come si impara a vedere anche ciò che non si vede? La domanda può avere come risposta solo interrogativi e riflessioni. La storia dell’umanità si è posta da sempre questo tema. Anassagora (più di duemila anni fa) diceva che “le cose che si vedono sono solo l’aspetto visibile di quelle che non si vedono”. Paul Klee ha passato la vita a cercare di “rendere visibile l’invisibile”. Maurice Merleau-Ponty, rovescia la frase di Anassagora e dice che il non visibile è “quel tessuto che fodera il visibile, lo sostiene, lo alimenta e che, dal canto suo, non è cosa, ma possibilità, latenza, carne delle cose”. Quando è morto Merleau-Ponty ha lasciato un’opera incompiuta intitolata Il Visibile e l’Invisibile (Bompiani).
Come si riesce a guidare un gioco teatrale mentre si impara a vedere/vedersi nel visibile/invisibile? Gaston Bachelard (La poetica della rêverie, Dedalo) ci offre l’idea di una “visione elastica”, che mantiene in ogni azione quella “utopia concreta” accennata all’inizio. E’ una condizione (come lui la chiama) di rêverie, di uno stato tra sogno e veglia, fra ideale e reale, un non visibile che al tempo stesso diventa visibile (con la scrittura, la poesia, il teatro). Da Bachelard rubiamo anche l’immagine della candela che rappresenta la tensione del “sognatore” che aspira alla verticalità perché “i sogni più grandi stanno sempre in cima”.
La fiamma del sognatore di utopie concrete si sostanzia di tre luminosità:
– La fiamma del piacere (divertimento – attitudine ludica). Chi non è lieto, non può rendere lieti gli altri. L’atteggiamento ludico non è superficialità. Casomai è leggerezza (come scrive Calvino nelle sue Lezioni americane) è un piacere non disgiunto dalla fatica, è uno sforzo senza la sofferenza, è una presenza affettuosa che mantiene una distanza accogliente. L’attitudine ludica non si identifica con il gioco. Non è il gioco che conta, ma il giocare, è il Play, non il Game. In quest’ottica non ci sono cose importanti (i compiti) e cose futili (i giochi): “Quando parlo o gioco con un bambino (scriveva Janus Korczak, Il diritto del bambino al rispetto, Edizioni dell’asino) un istante della mia vita si unisce a un istante della sua e questi due istanti hanno la stessa maturità”. In quest’ottica ci si può divertire a contare per sette fino a millanta, o a recitare filastrocche sconclusionate, a leggere poesie, a scriverle e a ripeterle, o anche ad immaginare e rappresentare la vita nascosta di un lombrico o i personaggi che popolano l’altra parte della luna … Il piacere di imparare e il piacere di insegnare. Il piacere di prendere e il piacere di dare. Il giocare con le cose che si conoscono e con quelle che non si sono ancora avvicinate. Una scuola di teatro per divertirsi da morire, o meglio per un divertirsi da vivere.
– La fiamma della tolleranza (accoglienza) per le cose che non paiono (a noi) importanti o per chi si trova ad essere “diverso” (es. diversamente abile, o extracomunitario). Il termine accoglienza deriva dal latino accõlo – che indicava lo stare vicino, l’abitare presso, il vivere accanto – e dal verbo colligere che ha il significato di legare assieme, unire. Per dare un senso attuale alla parola accogliere, ci potremmo riferire a questi significati. Accogliere un bambino che viene a “fare teatro” va aldilà delle situazioni di primo incontro; è piuttosto un ‘vivere accanto’, uno stare vicino che diviene quotidiano, un porsi nei confronti dell’altro (bambino e non) come ‘persona’ che sta di fianco (e non davanti) e che cerca di ricomporre (aiutando e aiutandosi a ricomporre) i frammenti delle esperienze personali e delle conoscenze culturali per trasformarle in “testo” (G. Staccioli, Diario dell’accoglienza, Conoscenza).
– La fiamma della pensosità che porta alla significatività, che conduce verso la costruzione di messaggi di senso. Una fiamma che si occupa di argomenti che toccano le bipolarità del singolo e di tutti gli altri: la timidezza e l’affermazione di sé, la dolcezza e la violenza, la sicurezza ed il rischio, l’ordine e il disordine, la voglia di vivere e la paura della morte, la dipendenza e l’autonomia, la tenerezza e la forza … (Ministère de l’Education Nationale, Les activités corporelles d’expression, EPS). Una pensosità che ha bisogno dei pensieri e dei progetti dei bambini. Il maestro Cesare Ghezzi insegnava ai suoi alunni a “cogliere il mondo attraverso la propria pensosa intimità” (Il bambino e la sua arte, Il Melangolo).
In tutte e tre queste luminosità (per riconoscerle, vederle, seguirle) occorre intraprendere la strada del “maestro clandestino”, quella ricordata da Martin Buber (Storie e leggende chassidiche, Mondadori): “Rabbi Loeb era il maestro clandestino che, seguendo il corso delle acqua, camminava per il mondo a salvare l’anima dei vivi e dei morti. Egli raccontò: Sono andato al Maestro Maggid non per avere il suo insegnamento, ma solo per vedere come slaccia le sue scarpe e come le riallaccia”.
La conclusione, allora, diventa: “ricordati ogni giorno: ciò che passa nella relazione adulto/bambino è … il modo con cui ciascuno si allaccia le scarpe”.
di Gianfranco Staccioli
Segretario Generale della Federazione Italiana dei CEMEA – Università di Firenze